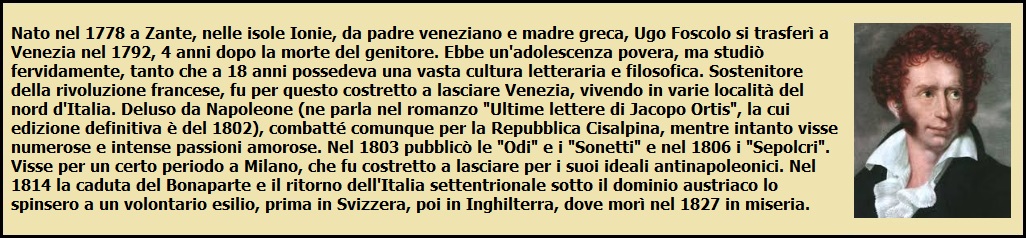Un vispo abate, da tutti creduto
un sant’uomo, invaghitosi della moglie di un rozzo sbruffone, lo rinchiude in
un sotterraneo, facendogli credere di essere capitato in Purgatorio, e intanto
si prende il suo piacere con la donna; quando questa rimane incinta, fa “resuscitare”
l’uomo, il quale con le sue parole contribuisce ad accrescere la santità dell’abate.
Stupenda novella in cui Boccaccio
intreccia abilmente tre tematiche ricorrenti nel Decameron: la pulsione
erotica, la credulità popolare in tema di religione e le astuzie peccaminose
del clero.
[Giornata terza: 8]
Ferondo, mangiata certa polvere,
è sotterrato per morto; e dall’abate, che la moglie di lui si gode, tratto
della sepoltura, è messo in prigione e fattogli credere che egli è in Purgatoro;
e poi risuscitato, per suo nutrica un figliuolo dello abate nella moglie di lui
generato.
[…] Carissime donne, a me si para
davanti a doversi far raccontare una verità che ha, troppo più che di quello
che ella fu, di menzogna sembianza; e quella nella mente m’ha ritornata l’avere
udito un per un altro essere stato pianto e sepellito. Dirò adunque come un
vivo per morto sepellito fosse, e come poi per risuscitato, e non per vivo,
egli stesso e molti altri lui credessero essere della sepoltura uscito, colui
di ciò essendo per santo adorato che come colpevole ne dovea più tosto essere
condannato.
Fu adunque in Toscana una badia,
e ancora è, posta, sì come noi ne veggiam molte, in luogo non troppo
frequentato dagli uomini, nella quale fu fatto abate un monaco, il quale in
ogni cosa era santissimo fuor che nell’opera delle femine: e questo sapeva sì
cautamente fare, che quasi niuno, non che il sapesse, ma né suspicava; per che
santissimo e giusto era tenuto in ogni cosa. Ora avvenne che, essendosi molto
con l’abate dimesticato un ricchissimo villano, il quale avea nome Ferondo,
uomo materiale e grosso senza modo (né per altro la sua dimestichezza piaceva
all’abate, se non per alcune recreazioni le quali talvolta pigliava delle sue
simplicità), e in questa dimestichezza s’accorse l’abate Ferondo avere una
bellissima donna per moglie, della quale esso sì ferventemente s’innamorò, che
ad altro non pensava né dì né notte. Ma udendo che, quantunque Ferondo fosse in
ogni altra cosa semplice e dissipato, in amare questa sua moglie e guardarla
bene era savissimo, quasi se ne disperava. Ma pure, come molto avveduto, recò a
tanto Ferondo, che egli insieme con la sua donna a prendere alcun diporto nel
giardino della badia venivano alcuna volta: e quivi con loro della beatitudine
di vita eterna e di santissime opere di molti uomini e donne passate ragionava
modestissimamente loro, tanto che alla donna venne disidero di confessarsi da
lui e chiesene la licenzia da Ferondo e ebbela.
Venuta adunque a confessarsi la
donna all’abate, con grandissimo piacere di lui e a’ piè postaglisi a sedere,
anzi che a dire altro venisse, incominciò: «Messere, se Idio m’avesse dato
marito o non me l’avesse dato, forse mi sarebbe agevole co’ vostri
ammaestramenti d’entrare nel camino che ragionato n’avete che mena altrui a
vita eterna; ma io, considerato chi è Ferondo e la sua stoltizia, mi posso dir
vedova, e pur maritata sono, in quanto, vivendo esso, altro marito aver non
posso; e egli, così matto come egli è, senza alcuna cagione è sì fuori d’ogni
misura geloso di me, che io per questo altro che in tribulazione e in mala
ventura con lui viver non posso. Per la qual cosa, prima che io a altra
confession venga, quanto più posso umilmente vi priego che sopra questo vi
piaccia darmi alcun consiglio, per ciò che, se quinci non comincia la cagione
del mio bene potere adoperare, il confessarmi o altro ben fare poco mi gioverà».
Questo ragionamento con gran
piacere toccò l’animo dell’abate, e parvegli che la fortuna gli avesse al suo
maggior disidero aperta la via, e disse: «Figliuola mia, io credo che gran noia
sia a una bella e dilicata donna, come voi siete, aver per marito un
mentecatto, ma molto maggior la credo essere l’avere un geloso; per che, avendo
voi e l’uno e l’altro, agevolmente ciò che della vostra tribulazion dite vi
credo. Ma a questo, brievemente parlando, niuno né consiglio né rimedio veggo
fuor che uno, il quale è che Ferondo di questa gelosia si guerisca. La medicina
da guerillo so io troppo ben fare, pur che a voi dea il cuore di segreto tenere
ciò che io vi ragionerò».
La donna disse: «Padre mio, di
ciò non dubitate, per ciò che io mi lascerei innanzi morire che io cosa dicessi
a altrui che voi mi diceste che io non dicessi; ma come si potrà far questo?»
Rispose l’abate: «Se noi vogliamo
che egli guerisca, di necessità convien che egli vada in Purgatorio».
«E come» disse la donna «vi potrà
egli andar vivendo?»
Disse l’abate: «Egli convien
ch’e’ muoia, e così v’andrà; e quando tanta pena avrà sofferta che egli di questa
sua gelosia sarà gastigato, noi con certe orazioni pregheremo Idio che in
questa vita il ritorni, e Egli il farà».
«Adunque,» disse la donna «debbo
io rimaner vedova?»
«Sì,» rispose l’abate «per un
certo tempo, nel quale vi converrà molto ben guardare che voi a alcun non vi
lasciate rimaritare, per ciò che Idio l’avrebbe per male, e, tornandoci Ferondo
vi converrebbe a lui tornare, e sarebbe più geloso che mai».
La donna disse: «Pur che egli di
questa mala ventura guerisca, che egli non mi convenea sempre stare in
prigione, io son contenta; fate come vi piace».
Disse allora l’abate: «E io il
farò; ma che guiderdone debbo io aver da voi di così fatto servigio?»
«Padre mio,» disse la donna «ciò
che vi piace, pur che io possa: ma che puote una mia pari, che a un così fatto
uomo, come voi siete, sia convenevole?»
A cui l’abate disse: «Madonna,
voi potete non meno adoperar per me che sia quello che io mi metto a far per
voi, per ciò che, sì come io mi dispongo a far quello che vostro bene e vostra
consolazion dee essere, così voi potete far quello che fia salute e scampo
della vita mia».
Disse allora la donna: «Se così
è, io sono apparecchiata».
«Adunque» disse l’abate «mi
donerete voi il vostro amore e faretemi contento di voi, per la quale io ardo
tutto e mi consumo».
La donna, udendo questo, tutta
sbigottita rispose: «Ohimè, padre mio, che è ciò che voi domandate? Io mi
credeva che voi foste un santo; or conviensi egli a’ santi uomini di richieder
le donne, che a lor vanno per consiglio, di così fatte cose?»
A cui l’abate disse: «Anima mia
bella, non vi maravigliate, ché per questo la santità non diventa minore, per
ciò che ella dimora nell’anima e quello che io vi domando è peccato del corpo.
Ma che che si sia, tanta forza ha avuta la vostra vaga bellezza, che amore mi
costrigne a così fare; e dicovi che voi della vostra bellezza più che altra
donna gloriar vi potete, pensando che ella piaccia a’ santi, che sono usi di
vedere quelle del cielo. E oltre a questo, come che io sia abate, io sono uomo
come gli altri e, come voi vedete, io non sono ancor vecchio. E non vi dee
questo esser grave a dover fare, anzi il dovete disiderare, per ciò che, mentre
che Ferondo starà in Purgatoro, io vi darò, faccendovi la notte compagnia,
quella consolazione che vi dovrebbe dare egli; né mai di questo persona alcuna
s’accorgerà, credendo ciascun di me quello, e più, che voi poco avante ne credavate.
Non rifiutate la grazia che Dio vi manda, ché assai sono di quelle che quello
disiderano che voi potete avere e avrete, se savia crederete al mio consiglio.
Oltre a questo, io ho di belli gioielli e di cari, li quali io non intendo che
d’altra persona sieno che vostra. Fate adunque, dolce speranza mia, per me
quello che io fo per voi volentieri».
La donna teneva il viso basso, né
sapeva come negarlo, e il concedergliele non le pareva far bene; per che l’abate,
veggendola averlo ascoltato e dare indugio alla risposta, parendogliele avere
già mezza convertita, con molte altre parole alle prime continuandosi, avanti che
egli ristesse, l’ebbe nel capo messo che questo fosse ben fatto; per che essa
vergognosamente disse sé essere apparecchiata a ogni suo comando, ma prima non
poter che Ferondo andato fosse in Purgatoro. A cui l’abate contentissimo disse:
«E noi faremo che egli v’andrà incontanente; farete pure che domane o l’altro
dì egli qua con meco se ne venga a dimorare»; e detto questo, postole
celatamente in mano un bellissimo anello, la licenziò. La donna, lieta del dono
e attendendo d’aver degli altri, alle compagne tornata maravigliose cose
cominciò a raccontare della santità dell’abate e con loro a casa se ne tornò.
Ivi a pochi dì Ferondo se n’andò
alla badia, il quale come l’abate vide, così s’avisò di mandarlo in Purgatoro.
E ritrovata una polvere di maravigliosa vertù, la quale nelle parti di Levante
avuta avea da un gran prencipe (il quale affermava quella solersi usare per lo
Veglio della Montagna, quando alcun voleva dormendo mandare nel suo Paradiso o
trarlone, e che ella, più e men data, senza alcuna lesione faceva per sì fatta
maniera più e men dormire colui che la prendeva, che, mentre la sua vertù
durava, non avrebbe mai detto colui in sé aver vita) e di questa tanta presane
che a far dormir tre giorni sufficiente fosse, e in un bicchier di vino non ben
chiaro ancora nella sua cella, senza avvedersene Ferondo, gliele diè bere: e
lui appresso menò nel chiostro e con più altri de’ suoi monaci di lui
cominciarono e delle sue sciocchezze a pigliar diletto. Il quale non durò guari
che, lavorando la polvere, a costui venne un sonno subito e fiero nella testa, tale
che stando ancora in piè s’addormentò e addormentato cadde. L’abate mostrando
di turbarsi dell’accidente, fattolo scignere e fatta recare acqua fredda e gittargliele
nel viso e molti suoi altri argomenti fatti fare, quasi da alcuna fumosità di
stomaco o d’altro che occupato l’avesse gli volesse la smarrita vita e ’l
sentimento rivocare, veggendo l’abate e’ monaci che per tutto questo egli non
si risentiva, toccandogli il polso e niun sentimento trovandogli, tutti per
constante ebbero ch’e’ fosse morto: per che, mandatolo a dire alla moglie e a’
parenti di lui, tutti quivi prestamente vennero; e avendolo la moglie con le
sue parenti alquanto pianto, così vestito come era il fece l’abate mettere in
uno avello.
La donna si tornò a casa, e da un
piccol fanciullin che di lui aveva disse che non intendeva partirsi giammai; e così
rimasasi nella casa il figliuolo e la ricchezza che stata era di Ferondo
cominciò a governare.
L’abate con un monaco bolognese,
di cui egli molto si confidava e che quel dì quivi da Bologna era venuto,
levatosi la notte, tacitamente Ferondo trassero della sepoltura e lui in una
tomba, nella quale alcun lume non si vedea e che per prigione de’ monaci che
fallissero era stata fatta, nel portarono; e trattigli i suoi vestimenti, a
guisa di monaco vestitolo sopra un fascio di paglia il posero e lasciaronlo
stare tanto che egli si risentisse. In questo mezzo il monaco bolognese, dallo
abate informato di quello che avesse a fare, senza saperne alcuna altra persona
niuna cosa, cominciò ad attender che Ferondo si risentisse.
L’abate il dì seguente con alcun
de’ suoi monaci per modo di visitazione se n’andò a casa della donna, la quale
di nero vestita e tribolata trovò: e confortatala alquanto, pianamente la
richiese della promessa. La donna, veggendosi libera e senza lo ’mpaccio di
Ferondo o d’altrui, avendogli veduto in dito un altro bello anello, disse che
era apparecchiata, e con lui compose che la seguente notte v’andasse. Per che,
venuta la notte, l’abate travestito de’ panni di Ferondo e dal suo monaco
accompagnato, v’andò e con lei infino al matutino con grandissimo diletto e
piacere si giacque e poi si ritornò alla badia, quel cammino per così fatto servigio
faccendo assai sovente. E da alcuni e nell’andare e nel tornare alcuna volta
essendo scontrato, fu creduto ch’e’ fosse Ferondo che andasse per quella contrada
penitenza faccendo, e poi molte novelle tralla gente grossa della villa
contatone, e alla moglie ancora, che ben sapeva ciò che era, più volte fu
detto.
Il monaco bolognese, risentito
Ferondo e quivi trovandosi senza saper dove si fosse, entrato dentro con una
voce orribile, con certe verghe in mano, presolo, gli diede una gran battitura.
Ferondo, piangendo e gridando, non
faceva altro che domandare: «Dove sono io?»
A cui il monaco rispose: «Tu se’
in Purgatoro».
«Come?» disse Ferondo «Dunque son
io morto?»
Disse il monaco: «Mai sì»; per
che Ferondo se stesso e la sua donna e ’l suo figliuolo cominciò a piagnere, le
più nuove cose del mondo dicendo.
Al quale il monaco portò alquanto
da mangiare e da bere; il che veggendo Ferondo disse: «O mangiano i morti?»
Disse il monaco: «Sì, e questo
che io ti reco è ciò che la donna che fu tua mandò stamane alla chiesa a far
dir messe per l’anima tua, il che Domenedio vuole che qui rappresentato ti
sia».
Disse allora Ferondo: «Domine,
dalle il buono anno! Io le voleva ben gran bene anzi che io morissi, tanto che
io me la teneva tutta notte in braccio e non faceva altro che basciarla e anche
faceva altro quando voglia me ne veniva»; e poi, gran voglia avendone, cominciò
a mangiare e a bere, e non parendogli il vino troppo buono, disse: «Domine,
falla trista! ché ella non diede al prete del vino della botte di lungo il muro».
Ma poi che mangiato ebbe, il
monaco da capo il riprese e con quelle medesime verghe gli diede una gran
battitura.
A cui Ferondo, avendo gridato
assai, disse: «Deh, questo perché mi fai tu?»
Disse il monaco: «Per ciò che
così ha comandato Domenedio che ogni dì due volte ti sia fatto».
«E per che cagione?» disse
Ferondo.
Disse il monaco: «Perché tu fosti
geloso, avendo la miglior donna che fosse nelle tue contrade per moglie».
«Oimè» disse Ferondo «tu di’
vero, e la più dolce: ella era più melata che ’l confetto, ma io non sapeva che
Domenedio avesse per male che l’uomo fosse geloso, ché io non sarei stato».
Disse il monaco: «Di questo ti
dovevi tu avvedere mentre eri di là e ammendartene; e se egli avvien che tu mai
vi torni, fa che tu abbi sì a mente quello che io ti fo ora, che tu non sii mai
più geloso».
Disse Ferondo: «O ritornavi mai
chi muore?»
Disse il monaco: «Sì, chi Dio
vuole».
«Oh!» disse Ferondo «se io vi
torno mai, io sarò il migliore marito del mondo; mai non la batterò, mai non le
dirò villania, se non del vino che ella ci ha mandato stamane: e anche non ci
ha mandato candela niuna, e èmmi convenuto mangiare al buio».
Disse il monaco: «Sì fece bene,
ma elle arsero alle messe».
«Oh!» disse Ferondo «tu dirai
vero: e per certo, se io vi torno, io le lascerò fare ciò che ella vorrà. Ma
dimmi, chi se’ tu che questo mi fai?»
Disse il monaco: «Io sono anche
morto, e fui di Sardigna; e perché io lodai già molto ad un mio signore l’esser
geloso, sono stato dannato da Dio a questa pena, che io ti debba dare mangiare
e bere e queste battiture infino a tanto che Idio dilibererà altro di te e di
me».
Disse Ferondo: «Non c’è egli più
persona che noi due?»
Disse il monaco: «Sì, a migliaia,
ma tu non gli puoi né vedere né udire se non come essi te».
Disse allora Ferondo: «O quanto
siam noi di lungi dalle nostre contrade?»
«Ohioh!» disse il monaco «sèvi di
lungi delle miglia più di be’ la cacheremo».
«Gnaffé! cotesto è bene assai!»
disse Ferondo «e per quel che mi paia, noi dovremmo essere fuor del mondo,
tanto ci ha».
Ora in così fatti ragionamenti e
in simili, con mangiare e con battiture, fu tenuto Ferondo da dieci mesi, infra
li quali assai sovente l’abate bene avventurosamente visitò la bella donna e
con lei si diede il più bel tempo del mondo. Ma, come avvengono le sventure, la
donna ingravidò e, prestamente accortasene, il disse all’abate: per che a ammenduni
parve che senza indugio Ferondo fosse da dovere essere di Purgatorio rivocato a
vita e che a lei si tornasse, e ella di lui dicesse che gravida fosse.
L’abate adunque la seguente notte
fece con una voce contrafatta chiamar Ferondo nella prigione e dirgli: «Ferondo,
confortati, ché a Dio piace che tu torni al mondo; dove tornato, tu avrai un
figliuolo della tua donna, il quale farai che tu nomini Benedetto, per ciò che
per gli prieghi del tuo santo abate e della tua donna e per amor di san
Benedetto ti fa questa grazia».
Ferondo, udendo questo, fu forte
lieto e disse: «Ben mi piace: Dio gli dea il buono anno a messer Domeneddio e
all’abate e a san Benedetto e alla moglie mia casciata, melata, dolciata».
L’abate, fattogli dare nel vino
che egli gli mandava di quella polvere tanta che forse quatro ora il facesse
dormire, rimessigli i panni suoi, insieme col monaco suo tacitamente il
tornarono nello avello nel quale era stato sepellito. La mattina in sul far del
giorno Ferondo si risentì e vide per alcuno pertugio dell’avello lume, il quale
egli veduto non avea ben dieci mesi; per che, parendogli esser vivo, cominciò a
gridare «Apritemi, apritemi!» ed egli stesso a pontar col capo nel coperchio
dello avello sì forte, che ismossolo, per ciò che poca ismovitura aveva, lo
’ncominciava a mandar via, quando i monaci, che detto avean matutino, corson
colà e conobbero la voce di Ferondo e viderlo già del monimento uscir fuori: di
che spaventati tutti per la novità del fatto cominciarono a fuggire e allo
abate n’andarono.
Il quale, sembianti faccendo di
levarsi d’orazione, disse: «Figliuoli, non abbiate paura; prendete la croce e
l’acqua santa e appresso di me venite, e veggiam ciò che la potenzia di Dio ne
vuol mostrare»; e così fece.
Era Ferondo tutto pallido, come
colui che tanto tempo era stato senza vedere il cielo, fuori dello avello
uscito; il quale, come vide l’abate, così gli corse a’ piedi e disse: «Padre
mio, le vostre orazioni, secondo che revelato mi fu, e quelle di san Benedetto
e della mia donna m’hanno delle pene del Purgatoro tratto e tornato in vita; di
che io priego Idio che vi dea il buono anno e le buone calendi, oggi e tuttavia».
L’abate disse: «Lodata sia la
potenza di Dio! Va dunque, figliuolo, poscia che Idio t’ha qui rimandato, e
consola la tua donna, la quale sempre, poi che tu di questa vita passasti, è
stata in lagrime, e sii da quinci innanzi amico e servidor di Dio».
Disse Ferondo: «Messere, egli m’è
ben detto così; lasciate far pur me, ché, come io la troverò, così la bascerò,
tanto bene le voglio».
L’abate, rimaso co’ monaci suoi,
mostrò d’avere di questa cosa una grande ammirazione e fecene divotamente
cantare il Miserere. Ferondo tornò
nella sua villa, dove chiunque il vedeva fuggiva, come far si suole delle
orribili cose, ma egli richiamandogli affermava sé essere risuscitato. La
moglie similmente aveva di lui paura.
Ma poi che la gente alquanto si
fu rassicurata con lui e videro che egli era vivo, domandandolo di molte cose,
quasi savio ritornato, a tutti rispondeva e diceva loro novelle dell’anime de’
parenti loro e faceva da sé medesimo le più belle favole del mondo de’ fatti
del Purgatoro: e in pien popolo raccontò la revelazione statagli fatta per la
bocca del Ragnolo Braghiello avanti che risuscitasse. Per la qual cosa in casa
con la moglie tornatosi e in possessione rientrato de’ suoi beni, la ’ngravidò
al suo parere, e per ventura venne che a convenevole tempo, secondo l’oppinion
degli sciocchi che credono la femina nove mesi appunto portare i figliuoli, la
donna partorì un figliuol maschio, il qual fu chiamato Benedetto Ferondi.
La tornata di Ferondo e le sue
parole, credendo quasi ogn’uomo che risuscitato fosse, acrebbero senza fine la
fama della santità dell’abate; e Ferondo, che per la sua gelosia molte
battiture ricevute avea, sì come di quella guerito, secondo la promessa dell’abate
fatta alla donna, più geloso non fu per innanzi; di che la donna contenta,
onestamente, come soleva, con lui si visse, sì veramente che, quando
acconciamente poteva, volentieri col santo abate si ritrovava, il quale bene e
diligentemente ne’ suoi maggior bisogni servita l’avea.
PARAFRASI IN ITALIANO MODERNO
Ferondo, mangiata certa polvere,
è sotterrato per morto; e dall’abate, che la moglie di lui si gode, tratto
della sepoltura, è messo in prigione e gli è fatto credere che egli è in Purgatorio;
e poi resuscitato, come fosse suo alleva un figliuolo generato dall’abate nella
moglie di lui.
[…] Carissime donne, mi si offre
il bisogno di raccontare un fatto vero, il quale più che di verità ha apparenza
di menzogna; e ciò mi è venuto in mente in quanto ho udito di uno che per un
altro era stato pianto e sepolto [ciò è
narrato nella novella precedente]. Dirò dunque di come un vivo fosse
sepolto credendolo morto, e come poi per risuscitato, e non per vivo, egli
stesso e molti altri credessero che lui era uscito dalla sepoltura, mentre colui
che meritava piuttosto di essere considerato colpevole venisse invece adorato come
un santo.
Ci fu dunque in Toscana una
badia, e ancora c’è, posta, così come noi ne vediamo molte, in luogo non troppo
frequentato dagli uomini, nella quale fu fatto abate un monaco, il quale in
ogni cosa era santissimo fuorché nei rapporti con le femmine: e questo sapeva così
cautamente fare, che quasi nessuno, non solo non lo sapeva, ma neppure lo
sospettava; per cui era considerato santissimo e giusto in ogni cosa. Ora
avvenne che, avendo molto familiarizzato con l’abate un ricchissimo villano, il
quale si chiamava Ferondo, uomo materiale e grossolano fuor di misura (né per
altro la sua dimestichezza piaceva all’abate, se non per un certo sollazzo che talvolta
ricavava dalle sue sciocchezze), in seguito a questa dimestichezza l’abate
s’accorse che Ferondo aveva una bellissima donna per moglie, della quale esso così
ferventemente s’innamorò, che ad altro non pensava né giorno né notte. Ma
udendo che, sebbene Ferondo fosse in ogni altra cosa semplice e sciocco, nell’amare
questa sua moglie e nel cusodirla bene era savissimo, quasi se ne disperava. Ma
pure, come molto avveduto, seppe trattare Ferondo in tal modo, che egli insieme
con la sua donna veniva a prendere qualche diporto nel giardino della badia di
tanto in tanto: e qui con loro ragionava modestissimamente della beatitudine
della vita eterna e di santissime opere di molti uomini e donne del passato,
tanto che alla donna venne desiderio di confessarsi da lui e ne chiese il
permesso a Ferondo e l’ottenne.
Venuta dunque la donna a
confessarsi dall’abate, con grandissimo piacere di lui e messasi a sedere ai
suoi piedi, prima di arrivare a parlare d’altro, incominciò: «Messere, se Iddio
m’avesse dato marito veramente [cioè se
me l’avesse dato assennato e di proposito] o non me l’avesse dato [piuttosto che darmelo così sciocco],
forse mi sarebbe agevole con i vostri ammaestramenti entrare nel cammino di cui
mi avete ragionato che conduce alla vita eterna; ma io, considerato chi è
Ferondo e la sua stoltezza, mi posso dire vedova, eppure sono maritata, in
quanto, finché lui è vivo, non posso avere altro marito; inoltre egli, così
stupido com’è, senza alcun motivo è così fuori d’ogni misura geloso di me, che
io per questo non posso vivere altro che in tribolazione e in mala ventura. Per
la qual cosa, prima che io passi a confessare altre cose, quanto più posso
umilmente vi prego che su questo vi piaccia darmi qualche consiglio, per ciò
che, se da qui non comincia la ragione del mio potere far bene, il confessarmi
o qualunque altra opera buona poco mi gioverà».
Questo ragionamento con gran
piacere toccò l’animo dell’abate, e gli parve che la fortuna gli avesse aperta
la via al suo maggiore desiderio, e disse: «Figliuola mia, io credo che sia una
gran noia per una bella e delicata donna, come voi siete, avere per marito un
mentecatto, ma credo che sia molto maggiore quella d’averne uno geloso; perciò,
avendo voi e l’uno e l’altro, credo agevolmente a ciò che dite della vostra
tribolazione. Ma a questo, per dirla in breve, non vedo alcun consiglio né
rimedio fuorché uno, e cioè che Ferondo guarisca di questa gelosia. La medicina
per guarirlo io la conosco bene, purché voi abbiate cuore di tenere segreto
tenere ciò che io vi spiegherò».
La donna disse: «Padre mio, di
ciò non dubitate, perché io mi lascerei morire piuttosto che dire a qualcuno
qualcosa che voi mi abbiate detto di non dire; ma come si potrà far questo?»
Rispose l’abate: «Se noi vogliamo
che egli guarisca, è necessario che egli vada in Purgatorio».
«E come» disse la donna «potrà
egli andarvi da vivo?»
Disse l’abate: «È necessario che
egli muoia, e così ci andrà; e quando avrà sofferto tanta pena da essere
castigato di questa sua gelosia, noi con certe orazioni pregheremo Iddio che lo
riporti in questa vita, ed Egli lo farà».
«Dunque,» disse la donna «devo io
rimanere vedova?»
«Sì,» rispose l’abate «per un
certo tempo, durante il quale vi converrà stare molto attenta affinché non vi
lasciate rimaritare ad alcuno [com’era
usanza che facessero il padre o i fratelli di una vedova], perché Iddio l’avrebbe
per male, e, tornando Ferondo in questo mondo vi converrebbe a lui tornare, ed
egli sarebbe più geloso che mai».
La donna disse: «Purché guarisca
di questa mala ventura, poiché non mi piaceva stare sempre in prigione, io son
contenta; fate come vi piace».
Disse allora l’abate: «E io lo
farò; ma che ricompensa devo io aver da voi per così fatto servizio?»
«Padre mio,» disse la donna «ciò
che vi piace, purché io possa: ma che può una mia pari, che a un così fatto
uomo, come voi siete, sia convenevole?»
Al che l’abate disse: «Madonna,
voi potete fare per me cosa non minore di quella che io sto per fare per voi,
dato che, proprio come io mi dispongo a fare quello che sarà il vostro bene e la
vostra consolazione, così voi potete fare quello che sarà salute e scampo della
vita mia».
Disse allora la donna: «Se così
è, io sono apparecchiata».
«Dunque» disse l’abate «voi mi
donerete il vostro amore e mi farete contento di voi, per cui io ardo tutto e
mi consumo».
La donna, udendo questo, tutta
sbigottita rispose: «Ohimè, padre mio, che è ciò che voi domandate? Io credevo
che voi foste un santo; da quando conviene ai santi uomini chiedere simili cose
alle donne, che vanno da loro per consiglio?»
Al che l’abate disse: «Anima mia
bella, non vi meravigliate, perché per questo la santità non diventa minore,
dato che ella dimora nell’anima e quello che io vi domando è peccato del corpo.
Ma sia quel che sia, tanta forza ha avuta la vostra vaga bellezza, che amore mi
costringe a far così; e vi dico che voi vi potete gloriare della vostra
bellezza più che qualunque altra donna, pensando che essa piace ai santi, che
sono abituati a vedere quelle del cielo. E oltre a questo, sebbene io sia
abate, io sono uomo come gli altri e, come voi vedete, non sono ancora vecchio.
E dover far questo non vi deve essere gravoso, anzi lo dovete desiderare, visto
che, mentre Ferondo starà in Purgatorio, io vi darò, facendovi compagnia la
notte, quella consolazione che egli vi dovrebbe dare; né mai di questo persona
alcuna si accorgerà, dato che ciascuno crede di me quello, e più, che voi poco
prima ne credevate. Non rifiutate la grazia che Dio vi manda, perché sono molte
quelle che desiderano ciò che voi potete avere e avrete, se savia crederete al
mio consiglio. Oltre a questo, io ho dei gioielli belli e preziosi, e io non
intendo che siano d’altri se non vostri. Fate dunque, dolce speranza mia, per
me quello che io faccio per voi volentieri».
La donna teneva il viso basso, né
sapeva come negare ciò che le veniva richiesto, e al concederlo non le pareva di
far bene; perciò l’abate, vedendo che aveva ascoltato e che indugiava nella
risposta, parendogli di averla già mezza convertita, aggiungendo molte altre
parole alle prime, avanti che egli smettesse di parlare, le ebbe messo nel capo
che questo fosse ben fatto; per cui essa vergognosamente disse di essere
apparecchiata a ogni suo comando, ma di non poterlo fare prima che Ferondo fosse
andato in Purgatorio. Al che l’abate contentissimo disse: «E noi faremo che egli
ci vada subito; e voi pure farete in modo che domani l’altro egli venga a
dimorare qua con me»; e detto questo, postole celatamente in mano un bellissimo
anello, la licenziò. La donna, lieta del dono e attendendo d’averne degli
altri, tornata alle compagne, meravigliose cose cominciò a raccontare della
santità dell’abate e con loro a casa se ne tornò.
Di lì a pochi giorni Ferondo se
n’andò alla badia, e appena lo vide l’abate si decise a mandarlo in Purgatorio.
E ritrovata una polvere di virtù meravigliosa, che aveva avuto nelle terre di
Levante da un gran principe (il quale affermava che era solito farne uso il
Veglio della Montagna, quando voleva mandare nel suo Paradiso o trarne fuori
qualcuno addormentato, e che essa, data in quantità maggiore o minore, senza
alcun danno faceva dormire di più o di meno colui che la prendeva, in modo che,
finché durava il suo effetto, non si sarebbe mai detto colui fosse vivo) e presane
di questa tanta da essere sufficiente a far dormire per tre giorni, la diede a
bere a Ferondo in un bicchiere di vino non ben chiaro mentre era ancora nella
sua cella, senza che lui se ne accorgesse: poi lo portò nel chiostro e assieme
con altri monaci cominciarono a prendere diletto di lui e delle sue
sciocchezze. Il quale non durò molto, dato che, facendo la polvere il suo
effetto, a costui venne un sonno improvviso e fiero nella testa, tale che,
mentre era ancora in piedi, si addormentò e addormentato cadde. L’abate,
mostrando di turbarsi per ciò che succedeva, fattigli slacciare gli abiti e
fatta recare dell’acqua fredda e gettatagliela nel viso e fatti fare molti suoi
altri argomenti, come se qualche
esalazione di vapori malefici per cattiva digestione o per altro motivo gli volesse togliere la vita smarrita e i
sensi, vedendo l’abate e i monaci che malgrado tutto questo egli non si
riprendeva, toccandogli il polso e non trovandogli alcuna manifestazione
vitale, tutti indubitabilmente pensarono che egli fosse morto: per cui, mandatolo
a dire alla moglie e ai parenti di lui, tutti qui prestamente vennero; e dopo
che la moglie con le sue parenti l’ebbe pianto a lungo, così vestito come era l’abate
lo fece mettere in un avello.
La donna se ne tornò a casa, e disse
che non intendeva mai separarsi da un piccolo fanciullino che aveva avuto da
lui; così si tenne in casa il figliuolo e cominciò ad amministrare la ricchezza
che era stata di Ferondo.
L’abate con un monaco bolognese,
di cui egli molto si fidava e che quel giorno da Bologna era qui venuto,
levatosi la notte, tacitamente trassero Ferondo dalla sepoltura e lo portarono
in un sotterraneo, nel quale non c’era alcun lume e che era stato adibito a
prigione dei monaci che fallissero; e toltigli i suoi vestimenti, vestitolo a
guisa di monaco, lo posero sopra un fascio di paglia e lo lasciarono stare
tanto che egli si svegliasse. In questo frattempo il monaco bolognese, informato
dall’abate di ciò che doveva fare, senza che nessun altro ne sapesse niente,
cominciò ad attendere che Ferondo si svegliasse.
L’abate il dì seguente con alcuni
dei suoi monaci fingendo una visita di cortesia se ne andò a casa della donna,
che trovò vestita di nero e abbattuta: e confortatala alquanto, pianamente le richiese
della promessa. La donna, vedendosi libera e senza l’impaccio di Ferondo o di
altri, avendogli veduto in dito un altro bell’anello, disse che era apparecchiata,
e con lui si accordò affinché la notte seguente andasse da lei. Per cui, venuta
la notte, l’abate travestito dei panni di Ferondo e dal suo monaco
accompagnato, vi andò e con lei si giacque fino al mattutino con grandissimo
diletto e piacere, poi se ne ritornò alla badia, facendo assai volte quel
cammino fatto per tale servizio. E incontrandosi con alcuni sia nell’andare sia
nel tornare alcune volte, fu creduto che egli fosse Ferondo che andasse per
quella contrada facendo penitenza, e poi ne nacquero molte chiacchiere tra la
gente rozza del villaggio, e queste furono più volte riportate alla moglie, che
ben sapeva qual era la verità.
Il monaco bolognese, quando
Ferondo si riprese e si trovò senza sapere dove fosse, entrato dentro con una
voce orribile, con certe verghe in mano, lo prese e gli diede una gran
battitura.
Ferondo, piangendo e gridando,
non faceva altro che domandare: «Dove sono io?»
Al che il monaco rispose: «Tu sei
in Purgatorio».
«Come?» disse Ferondo «Dunque sono
morto?»
Disse il monaco: «Ebbene sì»; al
che Ferondo cominciò a piangere se stesso e la sua donna e il suo figliuolo, dicendo
le più strane cose del mondo.
Al che il monaco portò alquanto
da mangiare e da bere; vedendo ciò Ferondo disse: «Oh che, mangiano i morti?»
Disse il monaco: «Sì, e questo
che io ti reco è ciò che la donna che fu tua mandò stamane alla chiesa perché fossero
dette messe per l’anima tua, il che Domeneddio vuole che qui presentato ti
sia».
Disse allora Ferondo: «Signore,
dalle il buon anno [esclamazione
popolaresca d’augurio del tipo “Signore benedicila”]! Io le volevo proprio
un gran bene prima di morire, tanto che io me la tenevo tutta la notte in
braccio e non facevo altro che baciarla e anche facevo dell’altro quando voglia
me ne veniva»; e poi, gran voglia avendone, cominciò a mangiare e a bere, e non
parendogli il vino troppo buono, disse: «Domine, falla trista! ché ella non
diede al prete quel vino della botte allato al muro».
Ma poi che mangiato ebbe, il
monaco da capo lo riprese e con quelle medesime verghe gli diede una gran
battitura.
Al che Ferondo, avendo gridato
assai, disse: «Deh, perché mi fai tu questo?»
Disse il monaco: «Perché così ha
comandato Domeneddio, che ogni giorno ciò ti sia fatto due volte».
«E per quale ragione?» disse
Ferondo.
Disse il monaco: «Perché tu fosti
geloso, avendo per moglie la miglior donna che fosse nelle tue contrade».
«Oimè» disse Ferondo «tu dici
vero, e la più dolce: ella era più dolce del confetto, ma io non sapevo che
Domeneddio avesse per male che l’uomo fosse geloso, perché non lo sarei stato».
Disse il monaco: «Di questo
dovevi tu accorgerti mentre eri di là e ammendartene; e se accade che tu mai vi
torni, fa che tu abbia così a mente quello che io ti faccio ora, che tu non sia
mai più geloso».
Disse Ferondo: «Ma chi muore può
tornare di là?»
Disse il monaco: «Sì, chi Dio
vuole».
«Oh!» disse Ferondo «se io mai vi
torno, io sarò il migliore marito del mondo; mai non la batterò, mai non le
dirò villania, se non del vino che ella ci ha mandato stamane: e anche non ci
ha mandato nessuna candela, e ho dovuto mangiare al buio».
Disse il monaco: «Sì che lo fece,
ma esse arsero alle messe».
«Oh!» disse Ferondo «tu dirai il vero:
e per certo, se io vi torno, io le lascerò fare ciò che ella vorrà. Ma dimmi,
chi sei tu che questo mi fai?»
Disse il monaco: «Anch’io morto,
e fui di Sardegna; e poiché io già molto lodai un mio signore per il fatto che
fosse geloso, sono stato dannato da Dio a questa pena, che io ti debba dare
mangiare e bere e queste battiture infino a tanto che Idio delibererà altro di
te e di me».
Disse Ferondo: «Non c’è altra
persona che noi due?»
Disse il monaco: «Sì, a migliaia,
ma tu non li puoi né vedere né udire così come essi te».
Disse allora Ferondo: «O quanto
siamo noi lontani dalle nostre contrade?»
«Ohioh!» disse il monaco «vi sei
di lungi delle miglia più di be’ la cacheremo [parole senza senso, dette per confondere ancor più Ferondo]».
«Gnaffé! cotesto è bene assai!»
disse Ferondo «e per quel che mi pare, noi dovremmo essere fuor del mondo,
tanto ci ha».
Ora in così fatti ragionamenti e
in simili, con mangiare e con battiture, fu tenuto Ferondo circa dieci mesi,
durante i quali assai sovente l’abate bene avventurosamente visitò la bella
donna e con lei si diede il più bel tempo del mondo. Ma, come avvengono le
sventure, la donna ingravidò e, prestamente accortasene, lo disse all’abate:
per cui a entrambi parve che senza indugio Ferondo dovesse dal Purgatorio essere
riportato in vita e che a lei tornasse, ed ella dicesse che era gravida di lui.
L’abate dunque la seguente notte con
una voce contraffatta fece chiamar Ferondo nella prigione e gli disse:
«Ferondo, confortati, ché a Dio piace che tu torni al mondo; dove, una volta tornato,
tu avrai dalla tua donna un figliuolo, che farai chiamare Benedetto, dato che
per le preghiere del tuo santo abate e della tua donna e per amor di san
Benedetto ti fa questa grazia».
Ferondo, udendo questo, fu assai
lieto e disse: «Ben mi piace: Dio gli dia il buono anno al signor Domeneddio e
all’abate e a san Benedetto e alla moglie mia piena di cacio [cioè saporita come un cibo con molto cacio],
melata, dolciata [aggettivi che
sottolineano la goffaggine del protagonista]».
L’abate, fattogli dare nel vino
che egli gli mandava di quella polvere tanta che forse quattro ore lo facesse
dormire, rimessigli i panni suoi, insieme col monaco suo tacitamente lo
riportarono nell’avello nel quale era stato seppellito. La mattina in sul far
del giorno Ferondo si risvegliò e vide della luce per qualche pertugio
dell’avello, cosa che egli non aveva veduto per ben dieci mesi; per cui,
parendogli di essere vivo, cominciò a gridare «Apritemi, apritemi!» ed egli
stesso a spingere col capo nel coperchio dell’avello così forte, che smossolo,
dato che si riusciva a smuoverlo con poco, incominciava ad aprirlo, quando i
monaci, che avevano detto mattutino, corsero colà e conobbero la voce di
Ferondo e lo videro già uscir fuori della tomba: al che tutti spaventati per la
novità del fatto cominciarono a fuggire e andarono dall’abate.
Il quale, facendo finta di aver
appena finito di pregare, disse: «Figliuoli, non abbiate paura; prendete la
croce e l’acqua santa e venite appresso a me, e vediamo ciò che la potenza di
Dio ci vuol mostrare»; e così fece.
Ferondo tutto pallido, come uno
che era stato tanto tempo senza vedere il cielo, era uscito fuori dall’avello; e,
come vide l’abate, gli corse ai piedi e disse: «Padre mio, le vostre orazioni,
secondo ciò che mi è stato rivelato, e quelle di san Benedetto e della mia
donna m’hanno tratto dalle pene del Purgatorio e riportato in vita; di che io
prego Iddio che vi dia il buono anno e i buoni mesi, oggi e sempre».
L’abate disse: «Lodata sia la
potenza di Dio! Va dunque, figliuolo, dato che Iddio ti ha qui rimandato, e
consola la tua donna, la quale sempre, dopo che tu lasciasti questa vita, è stata
in lagrime, e sii d’ora in poi amico e servitor di Dio».
Disse Ferondo: «Signore, già mi è
stato detto così; lasciate fare a me, perché, come io la troverò, così la bacerò,
tanto bene le voglio».
L’abate, rimasto con i monaci
suoi, mostrò d’avere di questa cosa una grande ammirazione e fece per questo cantare
devotamente il Miserere. Ferondo
tornò nella sua villa, dove chiunque lo vedeva fuggiva, come si suole fare
davanti a delle orribili cose, ma egli richiamandogli affermava che era risuscitato.
La moglie similmente aveva di lui paura.
Ma poi che la gente alquanto si
fu rassicurata con lui e videro che egli era vivo, facendogli domande su molte
cose, quasi ritornato savio, a tutti rispondeva e diceva loro notizie delle
anime dei parenti loro e inventava da sé medesimo le più belle favole del mondo
sui fatti del Purgatorio: e in mezzo ai suoi compaesani raccontò la rivelazione
che gli era stata fatta per la bocca del Ragnolo Braghiello [deformazione di Agnolo Gabriello, a
sottolineare ancora una volta la rozzezza di Ferondo] prima che
risuscitasse. Perciò tornato in casa con la moglie e rientrato in possesso dei
suoi beni, la ingravidò (secondo il suo parere), e per ventura avvenne che a convenevole
tempo, secondo l’opinione degli sciocchi che credono la femmina appunto portare
i figliuoli per nove mesi, la donna partorì un figliuolo maschio, il quale fu
chiamato Benedetto Ferondi.
Il ritorno di Ferondo e le sue
parole, dato che quasi tutti credevano che fosse risuscitato, accrebbero senza
fine la fama della santità dell’abate; e Ferondo, che per la sua gelosia aveva
ricevuto molte battiture, come se fosse guarito da quella, secondo la promessa
dell’abate fatta alla donna, più geloso non fu per innanzi; di che la donna
contenta, onestamente, come soleva, con lui si visse, solo che, quando
acconciamente poteva, volentieri col santo abate si ritrovava, il quale bene e
diligentemente l’aveva servita nei suoi maggiori bisogni.
Miniature da antichi manoscritti raffiguranti momenti diversi di questa novella